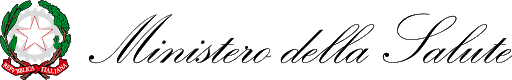Esce sulla rivista "Ospedali della Vita" un lavoro con titolo "Bologna Urgente"
Nell’ottobre 1977 esce, a firma Badiali–Vigna, un articolo con titolo "Bologna Urgente", che raccoglie ed elabora una serie di dati (tempi di percorrenza dei mezzi, tempi di risposta alle chiamate, ambulanze presenti sul territorio, ecc...) che migliorano – almeno dal punto di vista concettuale – l'applicabilità di un modello di centrale operativa unica, creando quindi un primo momento di raccordo tra l'ipotesi dell’Assessorato Comunale e l'ipotesi “Ce.P.I.S.” dell’Amministrazione degli Ospedali. L’articolo denuncia con dovizia di particolari le carenze del sistema di soccorso bolognese.
Nello stesso anno vari quotidiani riprendono i concetti espressi nell’articolo "Bologna Urgente". Lo stesso articolo viene ripreso anche a livello del Consiglio comunale di Bologna. In tale contesto viene fatto riferimento anche alla disorganizzazione riscontrata nei soccorso alle vittime dell’attentato all’Italicus del 1974*. L’Assessore Loperfido, condividendo le preoccupazioni sulla situazione bolognese, confermò che il servizio di soccorso territoriale era complessivamente svolto con gravi carenze ma nel contempo sottolineò che “.. Non abbiamo desistito dal nostro proposito .. Recentemente abbiamo ripreso i contatti collegiali; ... Si ha l'impressione che stia maturando in tutti (o nella gran parte) una disponibilità nuova ....”.
*La Strage dell'Italicus fu un attentato terroristico compiuto nella notte del 4 agosto 1974 a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, in prossimità della lunga galleria ferroviaria “Direttissima” poi teatro nel 1984 del più grave attentato del Natale 1984. Una bomba ad alto potenziale esplose alle 1:23 nella vettura 5 dell'espresso Roma-Monaco di Baviera via Brennero. Nell'attentato morirono 12 persone e altre 48 rimasero ferite. I soccorsi furono particolarmente caotici, tanto che gran parte dei feriti, pur trovandosi nel versante bolognese, furono soccorsi dalle ambulanze provenienti da più lontane postazioni della Toscana
Il Ce.P.I.S. organizza i soccorsi alle vittime del deragliamento ferroviario di Murazze di Vado
Il 15 aprile 1978 a Murazze di Vado, in provincia di Bologna, la locomotiva del treno espresso Lecce–Milano, in seguito a una frana, urta il rapido «Freccia della Laguna» Bolzano–Roma che deraglia: 48 morti e 76 feriti. Si tratta del più grave incidente ferroviario del dopoguerra. L’incidente è localizzato in pieno Appennino, a 30 km da Bologna e la scena che si presenta ai soccorritori è descritta come allucinante. Le cronache del tempo riferiscono che “il treno 572 bis, deviato dalla linea adriatica per interruzione, deraglia a causa di una frana presso Murazze di Vado, sulla linea Firenze–Bologna. L'incidente a prima vista sembra meno grave del previsto ma alcuni secondi dopo sopraggiunge sul binario opposto il rapido 813 "Freccia della Laguna". L'urto diviene inevitabile e provoca il deragliamento del rapido che precipita quasi totalmente nella scarpata adiacente".
Sul posto intervengono varie organizzazioni di soccorso, unitamente a mezzi del Ce.P.I.S. È uno dei primi casi in cui le ambulanze appartenenti agli ospedali e prevalentemente dedicate al trasporto interospedaliero, ma ben attrezzate e organizzate via radio dalla centrale operativa del Maggiore, intervengono su uno scenario incidentale così complesso con personale medico e infermieristico della Rianimazione del Maggiore. Per la prima volta mi trovo a lavorare su uno scenario simile. Fu anche estremamente formativo, in quanto si applicò, per la prima volta, una strategia di triage dei pazienti.

Lo smistamento dei feriti venne in gran parte organizzato dal Ce.P.I.S. Parte delle salme furono fatte affluire al Maggiore. È la prima positiva entrata in azione del Ce.P.I.S.: Comune e Amministrazione Ospedali rileveranno con soddisfazione il buon grado di efficienza della struttura pubblica. Tale evento è ritenuto tra i più complessi mai affrontati dalle centrali operative della Regione Emilia–Romagna. L’efficienza dei soccorsi fu favorita dalla presenza, accanto all’area incidentale, dell’Autostrada A1, ma soprattutto dal fatto che per la prima volta su uno scenario così caotico furono impiegati medici e infermieri dell’Ospedale, applicando schemi operativi specifici per le maxi emergenze e che la struttura pubblica aveva avuto già allora la capacità di sviluppare.
Radicale aggiornamento del progetto Ce.P.I.S.: responsabilità affidata alla Direzione Sanitaria e assegnazione del primo Infermiere Professionale
Fin dal mio ingresso nella Rianimazione del Maggiore avvenuta nel 1976, il Prof Nanni Costa mi assegna una quota oraria da svolgere al Ce.P.I.S. Nell’ottobre 1979 vengo definitivamente assegnato dal Prof. Stefano Damilano (Direttore Sanitario dell’Ospedale Maggiore) al Ce.P.I.S. con funzioni di coordinamento. Il servizio opera sotto la responsabilità della Direzione Sanitaria ed in particolare del Dott. Lino Nardozzi (Vice Direttore Sanitario), protagonista e appassionato sostenitore della necessità di innovare il servizio di soccorso territoriale. Si tratta del primo caso in Italia che segnerà il debutto di un nuovo modello gestionale, poi ripreso nel tempo da varie realtà nel percorso di costituzione dei servizi di emergenza. La mia assegnazione viene motivata dalla necessità di riattivare l’originario progetto che prevedeva la gestione di tutti i servizi di soccorso da parte del Ce.P.I.S.
Nel novembre 1979 viene presentato all'Assessorato Sanità del Comune, e alle neonate Unità Sanitarie Locali della Provincia di Bologna, un nuovo e più preciso programma a mia firma. Nel progetto vengono definite nuove strategie operative ed amministrative, in particolare le convezioni con C.R.I. e Volontariato, per la messa in funzione di una centrale operativa unificata all’interno della quale integrare le varie realtà bolognesi. Questo modello innova il precedente che prevedeva l’esclusivo affidamento delle attività urgenti al solo soggetto pubblico.
Nello stesso mese il Ce.P.I.S. viene trasferito dalla vecchia sede (ormai molto ridotta rispetto alla originale dotazione di spazi, visto che dopo il 1974, non decollando il progetto iniziale, i vari ambienti erano stati in gran parte utilizzati da altri servizi) a una nuova sede posta all’esterno del blocco ospedaliero (la ex portineria dell’Ospedale Maggiore). Tra la fine del 1979 e il luglio del 1980 si provvede a una rapida infrastrutturazione tecnologica del sistema: vengono attivate le prime linee dirette con le varie Croci e gli ospedali e si estende alle ambulanze esterne il moderno sistema radio del Ce.P.I.S.